
Ennesimo colpo al Jobs act: un’altra parte della riforma renziana è stata dichiarata incostituzionale
La Corte costituzionale ha riconosciuto l’eccesso di delega rispetto all’art. 2 co. 1 del d.lgs. 23/2015: limitando la reintegrazione alle sole nullità espressamente previste, il governo Renzi violava le indicazioni parlamentari, creando vuoto di tutela anche per casi gravi come i licenziamenti ritorsivi.
fanpage – 24 febbraio 2024 di Roberta Covelli
Sono passati dieci anni dall’insediamento del governo Renzi e, all’indomani di questo decimo anniversario, la  Corte Costituzionale ha emesso una nuova sentenza sul Jobs act, uno degli atti simbolo dell’esecutivo renziano. La censura della Consulta colpisce ancora una volta il decreto legislativo 23 del 2015, abrogando un avverbio, “espressamente”, e così allargando l’applicazione della reintegra a tutti i casi di nullità del licenziamento. Ma, per comprendere la pronuncia del giudice costituzionale, occorre aver presente tanto le prerogative governative e parlamentari, quanto la logica di fondo della riforma del lavoro renziana.
Corte Costituzionale ha emesso una nuova sentenza sul Jobs act, uno degli atti simbolo dell’esecutivo renziano. La censura della Consulta colpisce ancora una volta il decreto legislativo 23 del 2015, abrogando un avverbio, “espressamente”, e così allargando l’applicazione della reintegra a tutti i casi di nullità del licenziamento. Ma, per comprendere la pronuncia del giudice costituzionale, occorre aver presente tanto le prerogative governative e parlamentari, quanto la logica di fondo della riforma del lavoro renziana.
La logica del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs act
Elemento centrale del cosiddetto Jobs act era l’introduzione del contratto a tutele crescenti, divenuto il rapporto di lavoro dipendente tipo per tutti gli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015.
In realtà, il nuovo contratto non ha nulla di diverso dai contratti stipulati prima di quella data, se non per la disciplina contro i licenziamenti illegittimi, che risulta particolarmente ridotta.
La logica di fondo del progetto renziano era infatti la riduzione delle tutele contro il recesso ingiustificato, attraverso la previsione di rimedi indennitari: secondo le intenzioni di chi scrisse la riforma, la sanzione principale contro un licenziamento ingiusto sarebbe dovuta essere una somma di denaro, prevedibile dal datore di lavoro, calcolata sulla base della sola anzianità di servizio del lavoratore entro un minimo e un massimo (inizialmente da 4 a 24 mensilità, poi innalzate dal cosiddetto decreto dignità in un intervallo da 6 a 36 mensilità).
Restavano salve alcune eccezioni, per i casi più gravi: il decreto legislativo 23/2015 prevede infatti ancora il rimedio della reintegrazione nei casi di licenziamento discriminatorio o nullo “perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.
Ma è proprio questa locuzione, contenuta al comma 1 dell’art. 2, ad aver richiesto l’attenzione della Consulta, in quanto difforme dalla delega parlamentare.
L’eccesso di delega: il decreto legislativo non rispetta le indicazioni parlamentari
I decreti legislativi, come anche il 23 del 2015, sono infatti atti delegati al governo dal Parlamento. Anche se il  potere di legiferare spetta alle Camere, queste possono comunque delegarlo all’esecutivo, ma “soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e “con determinazione di principi e criteri direttivi”.
potere di legiferare spetta alle Camere, queste possono comunque delegarlo all’esecutivo, ma “soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e “con determinazione di principi e criteri direttivi”.
Questo è accaduto anche per il Jobs act. Sul finire del 2014, il governo Renzi fece approvare al Parlamento una legge delega in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, e, nei primi mesi del 2015, furono emanati i decreti attuativi riferiti a quella delega.
Tuttavia, mentre la legge delega prevedeva la conservazione del «diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», il testo del decreto attuativo renziano ha ulteriormente ridotto lo spazio per il rimedio reale. La reintegrazione è infatti prevista in caso di discriminazione e per (rarissimi) casi di licenziamento disciplinare irrogati in assenza del fatto materiale contestato, mentre i casi di nullità del licenziamento sono differenziati: la reintegrazione non è prevista per tutti i casi di recesso nullo, ma solo per quelli “espressamente previsti dalla legge”.
Il vuoto di tutela per i lavoratori vittime di licenziamenti nulli
La Corte Costituzionale, allora, ha riconosciuto fondata la questione di legittimità, rilevando un eccesso di delega: il governo non ha rispettato i criteri direttivi posti dalla legge delega parlamentare, arrogandosi un potere normativo che non aveva.
La censura non è però solo di metodo, ma anche di merito. Con l’aggiunta dell’avverbio “espressamente”, ora abrogato dalla Consulta, diverse ipotesi di licenziamento nullo venivano escluse non solo dal rimedio reintegratorio, ma dalla stessa attenzione dell’ordinamento. Si crea così un vuoto di tutela rispetto a gravi violazioni dei diritti dei lavoratori: senza prevedere esplicitamente altri rimedi, il decreto legislativo renziano esclude dalla reintegrazione i casi di licenziamenti nulli, come illegittimi recessi per malattia (senza superamento del periodo di comporto), o irrogati in violazione del blocco dei licenziamenti, o in violazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, o, più in generale, in caso di licenziamenti ritorsivi, nulli per motivo illecito determinante.
l rimprovero della Corte Costituzionale appare particolarmente serio se si pensa che la nullità è la più grave forma di invalidità di un atto giuridico, che risulta viziato al punto da (dover) essere inefficace e che invece, nell’originale formulazione del Jobs act, continuava a produrre effetti e non meritava nemmeno una forma di tutela esplicita.
l nuovo monito della Consulta: serve una riforma che tuteli i lavoratori
Non è la prima volta che il decreto legislativo 23/2015 incappa nelle censure della Corte costituzionale. La Consulta già nel 2018 aveva scardinato il meccanismo centrale delle tutele crescenti, rilevando come il sistema automatico di calcolo basato sulla sola anzianità di servizio fosse incostituzionale alla luce della “inidoneità dell’indennità medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente”.
La stessa critica era arrivata nel 2020 dal Comitato europeo dei diritti sociali di Strasburgo, che, su reclamo collettivo della Cgil, aveva dichiarato che, a causa della riforma del lavoro renziana, l’Italia viola il diritto di lavoratrici e lavoratori di ricevere un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione in caso di licenziamento illegittimo.
E se di recente le norme sui licenziamenti collettivi illegittimi non hanno ricevuto censure dalla Consulta, valutando altre parti del Jobs act, tanto nel 2020, quanto nel 2022, il giudice costituzionale ha avuto modo di 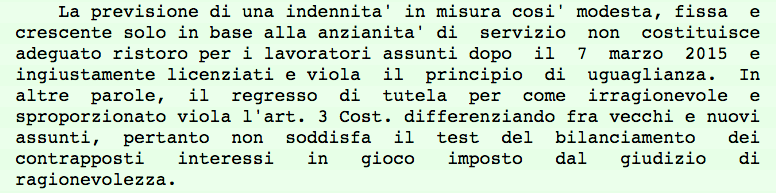 criticare la frammentarietà e illogicità delle tutele risultanti dalle riforme più recenti, richiamando il legislatore al suo ruolo: occorre infatti che il Parlamento si impegni nel rendere migliore, e più rispettosa dei diritti dei lavoratori, la normativa in materia di tutele contro il licenziamento ingiustificato.
criticare la frammentarietà e illogicità delle tutele risultanti dalle riforme più recenti, richiamando il legislatore al suo ruolo: occorre infatti che il Parlamento si impegni nel rendere migliore, e più rispettosa dei diritti dei lavoratori, la normativa in materia di tutele contro il licenziamento ingiustificato.
Anche con quest’ultima sentenza, che prevede la reintegrazione come rimedio logico per tutti i casi di licenziamenti nulli, e non solo per quelli espressamente previsti dalle leggi come tali, la Corte Costituzionale rinnova il suo monito: è dovere del legislatore “ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari”.
Nonostante le ormai quasi costanti dichiarazioni di incostituzionalità da parte della Consulta, risulta tuttavia difficile nutrire qualche speranza nell’azione della classe politica attualmente al potere. Se il Jobs act fu votato dal Partito democratico renziano, la precedente riforma Fornero (non esente da vizi di incostituzionalità), che modificava l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fu approvata da una maggioranza bipartisan, che comprendeva anche coloro che oggi governano (Giorgia Meloni compresa). Da un esecutivo come l’attuale, che non ha esitato a usare la retorica del lavoro per danneggiare i lavoratori, smontando i sussidi in caso di disoccupazione, calpestando il diritto allo sciopero, svuotando le proposte sul salario minimo legale, confondendo la flessibilità col precariato e rintuzzando la costante contrapposizione tra dipendenti e partite iva, risulta francamente difficile aspettarsi un impegno per il miglioramento delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati.
https://www.fanpage.it/politica/ennesimo-colpo-al-jobs-act-unaltra-parte-della-riforma-renziana-e-stata-dichiarata-incostituzionale/
https://www.fanpage.it/
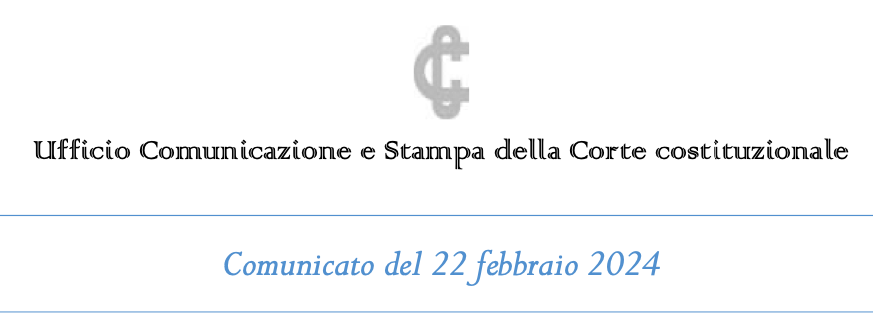
La Corte costituzionale (sentenza n. 22 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
La Corte di cassazione rimettente, nel sollevare la questione, aveva censurato tale limitazione, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), deducendo che l’esclusione delle nullità, diverse da quelle «espresse», non trovasse rispondenza nella legge di delega, la quale riconosceva la tutela reintegratoria nei casi di “licenziamenti nulli” senza distinzione alcuna.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata questa censura, osservando in particolare che il criterio direttivo, nella parte rilevante in proposito, aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e prevedendola, in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare.
La Corte ha sottolineato che il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva – e non consentiva quindi – la distinzione tra nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione soltanto per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.
Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.
Roma, 22 febbraio 2024
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 – Roma – Tel. 06.4698224/06-4698378
Judgment 22/2024 (ECLI:IT:COST:2024:22), Deposito del 22/02/2024
Licenziamenti, precarietà, appalti: ecco i referendum Cgil
Note:
Tra i decreti attuativi varati dal governo Renzi l’elemento centrale e qualificante della riforma è il decreto legislativo 23 del 2015, che introduce il nuovo contratto a tutele crescenti, applicato automaticamente a tutti i lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. A dispetto del nome, non c’è  nessuna riforma della tipologia contrattuale: l’unica differenza rispetto al passato è il regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo, con il rimedio monetario come soluzione principale e la reintegrazione sul posto di lavoro riservata ai soli licenziamenti nulli o discriminatori. Nella sua versione originaria, che, come si vedrà, è stata dichiarata incostituzionale e smontata dalla Consulta tra il 2018 e il 2020, l’indennità di risarcimento era calcolata automaticamente e legata all’anzianità di servizio: al lavoratore ingiustamente licenziato, in caso di vittoria di lite, sarebbe spettata un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, entro minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità (poi aumentate, dal decreto Dignità, tra sei e trentasei). Di fatto, insomma, l’istituzione del nuovo contratto era solo un modo per disapplicare, indirettamente e progressivamente, le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
nessuna riforma della tipologia contrattuale: l’unica differenza rispetto al passato è il regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo, con il rimedio monetario come soluzione principale e la reintegrazione sul posto di lavoro riservata ai soli licenziamenti nulli o discriminatori. Nella sua versione originaria, che, come si vedrà, è stata dichiarata incostituzionale e smontata dalla Consulta tra il 2018 e il 2020, l’indennità di risarcimento era calcolata automaticamente e legata all’anzianità di servizio: al lavoratore ingiustamente licenziato, in caso di vittoria di lite, sarebbe spettata un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, entro minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità (poi aumentate, dal decreto Dignità, tra sei e trentasei). Di fatto, insomma, l’istituzione del nuovo contratto era solo un modo per disapplicare, indirettamente e progressivamente, le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
L’unica certezza è l’instabilità, e questo è in realtà anche un problema per le imprese: non essendoci più una tutela reale, ossia una prospettiva di reintegrazione sul posto di lavoro in caso di licenziamento illecito, il lavoratore non è in grado di esercitare i suoi diritti al meglio durante il rapporto professionale, per il timore di ritorsioni che lo porterebbero a perdere l’impiego.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non è più una forma stabile di impiego.
NB: Qualsiasi opinione, consiglio, comunicato o altre informazioni espresse o rese disponibili da terzi e riportate sul nostro sito sono ben accette anche se non sono attribuibili né sono necessariamente condivise da Fedaiisf bensì ai rispettivi autori.





