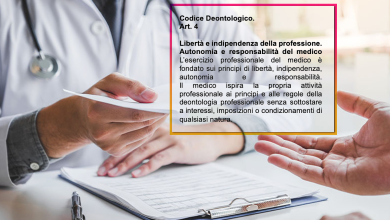La nuova disciplina sposta gli equilibri del conflitto di interessi a favore delle imprese. Il sindacato deve reagire puntando sulla contrattazione, spingendo le aziende a investire su qualità e stabilità del lavoro
di Franco Scarpelli Ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli studi di Milano-Bicocca
È ormai vicino alla definitiva approvazione il più atteso tra i decreti attuativi della legge 183 del 2014, quello sul cosiddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (Ctc). Potranno esservi modifiche marginali, ma la scelta compiuta è assai chiara. Il senso della disciplina, secondo le intenzioni del governo, dovrebbe essere quello di rendere più conveniente e appetibile per le imprese l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato, così contribuendo a dirottare una maggior quota della domanda di lavoro dai contratti di lavoro atipici e precari (contratti a termine, lavoro accessorio, rapporti di collaborazione autonoma ecc.) al contratto, appunto, a tempo indeterminato.
Sotto questo profilo, il decreto va messo in collegamento con le disposizioni contenute nella legge di stabilità, che ha previsto alcuni significativi sgravi contributivi proprio per le assunzioni a tempo indeterminato. D’altro canto, bisognerà attendere di vedere se e come saranno modificate le discipline dei rapporti di lavoro atipici (soprattutto quelle dei contratti a termine e delle collaborazioni), per capire se davvero il Ctc possa essere un loro adeguato “competitore”. Se questa è l’intenzione, in astratto apprezzabile, la sua realizzazione avviene con scelte regolative molto discutibili, la più rilevante delle quali è puntare – assecondando una retorica che pervade da anni il dibattito sulle politiche del lavoro – sui minori vincoli per il licenziamento.
La convenienza offerta alle imprese per fare ricorso al nuovo contratto a tempo indeterminato (a parte gli incentivi economici, allo stato previsti per il solo 2015) sta infatti tutta e soltanto nella forte attenuazione delle regole protettive in caso di licenziamento ingiusto, limitando a pochi casi (e solo per il licenziamento disciplinare) la reintegrazione nel posto di lavoro e prevedendo nella maggioranza dei casi che il lavoratore licenziato senza il rispetto dei limiti legali riceva un mero indennizzo economico. Indennizzo peraltro piuttosto modesto, sottratto alla valutazione discrezionale del giudice e fissato dalla legge in proporzione all’anzianità (due mesi di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24): dunque, nei prossimi anni, dato che la regola si applicherà ai nuovi assunti, gli indennizzi rimarranno su livelli assai contenuti.
È evidente a chiunque che con la nuova disciplina vengono modificati gli assetti di fondo del sistema di regole del lavoro (almeno per le imprese di maggiore dimensione, dove opera tradizionalmente un regime protettivo intenso per i licenziamenti ingiusti), spostando in misura significativa gli equilibri del conflitto di interessi nei rapporti di lavoro a favore dei datori di lavoro. Le tutele dei licenziamenti hanno infatti una rilevanza che va ben oltre la specifica vicenda del recesso e la tutela della stabilità di reddito e occupazione, poiché sostengono la forza contrattuale del lavoratore nella relazione quotidiana sul luogo di lavoro. Di più: una tutela efficace nei confronti di un licenziamento ipoteticamente ingiustificato – diritto non a caso espressamente sancito dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalla Carta sociale europea – protegge le libertà fondamentali nei luoghi di lavoro: la loro libertà di espressione e di dissenso, la difesa della propria dignità quando questa sia minacciata da superiori o colleghi, la difesa e pretesa dei propri diritti e della propria sicurezza, la possibilità di attivarsi sindacalmente se lo si desidera, l’effettività nel ricorso agli strumenti di conciliazione tra lavoro e vita privata ecc.
Ciò detto, e non è poco, preoccupano altresì i possibili effetti negativi di sistema connessi ai segnali che la nuova disciplina indirizza agli operatori economici, inevitabilmente orientando le scelte organizzative d’impresa nella gestione del fattore lavoro. Sotto questo profilo, la scelta legislativa – influenzata dalla richiamata retorica sulla competitività dell’impresa – sembra essere stata assunta al di fuori di una visione organica e complessa del sistema economico e del mercato del lavoro. In primo luogo, è evidente che legare il costo del licenziamento all’anzianità, secondo un rapporto fisso, può indurre l’impresa a preferire – almeno per le posizioni di professionalità più facilmente fungibile – un ricambio frequente della manodopera, disincentivando gli investimenti sulla crescita della professionalità per i dipendenti estranei ai core-workers.
Il rapporto a tempo indeterminato potrà forse, in parte, sostituire i rapporti atipici, ma diventando anch’esso un rapporto precario (sia nel senso classico della ridotta stabilità, sia nel senso di precarietà professionale). Nell’immediato, tuttavia, assume ancora più rilevanza la distinzione tra “vecchi” e “nuovi” assunti, con netta convenienza economica e normativa per i secondi (portata al massimo, in questo momento, dalla combinazione di sgravi contributivi e regime protettivo meno vincolante). Con riferimento a tale elemento preoccupa la possibilità di alcuni effetti negativi:
• un aumento di rigidità delle transizioni sul mercato del lavoro (e degli accordi individuali di flessibilità in uscita negoziata, incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro ecc.): gli attuali dipendenti, che continuano a godere del regime protettivo del vecchio articolo 18, saranno comprensibilmente assai meno disponibili a mettersi in gioco sul mercato di lavoro, nel momento in cui la transizione ad altra impresa significa (diventando “nuovi assunti”) un mutamento radicale dello statuto protettivo;
• il dualismo, all’interno della stessa impresa, tra vecchi e nuovi assunti (a tempo indeterminato), ripropone in maniera inedita quello già conosciuto tra lavoratori standard e atipici, ma oggi nell’ambito della stessa forma contrattuale; ancor più di quanti avvenuto sinora, l’impresa sarà incentivata a sostituire i dipendenti di maggiore anzianità con neoassunti, accentuando le tensioni interne e quelle sul mercato del lavoro e rendendo più grave l’emergenza sociale ed economica della disoccupazione in età elevate (con relativa dispersione di capitale umano);
• la netta convenienza nel ricorso ai nuovi assunti pesa come un macigno sulla possibilità che i lavoratori attualmente impiegati come apprendisti siano confermati in servizio (anche perché a tale forma contrattuale sembrano inapplicabili gli incentivi, anche per le nuove assunzioni);
• per le organizzazioni sindacali diventerà ancora più complicato sviluppare forme di rappresentanza unitaria su interessi collettivi omogenei; sarà inevitabile la riduzione di radicamento tra i lavoratori nuovi assunti, esposti a maggior rischio ove si attivino sindacalmente; d’altro lato, il maggior radicamento tra i lavoratori oggi già in servizio rischierà di aumentare le tensioni dei meccanismi di rappresentanza. Si tratta di elementi preoccupanti, che non aiutano l’auspicato sviluppo di una più robusta e partecipativa contrattazione aziendale.
Vi sono poi da considerare i possibili effetti distorsivi della concorrenza, destinati a manifestarsi soprattutto in quei settori economici nei quali l’organizzazione produttiva è sempre più frammentata e articolata su pluralità di soggetti, e in particolare in quelli dove si lavora su appalti (o forme contrattuali analoghe, quali i contratti di trasporto) e dove vi sono frequenti successioni nelle imprese esecutrici dei servizi, con condizioni di concorrenza sempre più esasperate. Qui deve temersi in primo luogo lo sviluppo di “start-up” imprenditoriali preordinate ad avvalersi dei vantaggi dell’operare con nuovi assunti, con serio danno per le imprese già presenti in quei mercati (e per i loro dipendenti). Un simile fenomeno accentuerebbe la già preponderante tendenza alla frammentazione dei soggetti imprenditoriali sul mercato, abbassandone ulteriormente qualità e consistenza.
Lo stesso fenomeno può costituire una seria minaccia per le clausole sociali negli appalti. L’articolo 7 dello schema di decreto prevede, giustamente, che nei cambi di appalto i lavoratori che passano in capo al cessionario (come nuovi assunti, assoggettati al regime del Ctc), conservano l’anzianità già maturata (pur collegata, discutibilmente, non all’anzianità di servizio del dipendente ma a quella sullo specifico appalto). Ma quante imprese saranno ancora disponibili ad assoggettarsi alle clausole sociali, nel momento in cui ciò significa assumere dipendenti con anzianità di servizio più elevate (e, dunque, potenzialmente più costosi in caso di licenziamento)? Per le imprese che applicano il contratto collettivo che le prevede è chiaro che le clausole sociali sono un obbligo, ma il rischio è di accentuare la già presente fuga da tali contratti, o di far sorgere più frequenti contenziosi.
Un possibile effetto potrà aversi anche sul fenomeno delle esternalizzazioni di attività o parti (“rami”) di azienda. Se finora, e da qualche decennio, vi è stata la tendenza ad accentuare tale fenomeno, per ridurre le dimensioni dell’impresa e liberarsi di attività e relativi dipendenti considerati meno strategici, la nuova disciplina rischia di frenarlo sensibilmente. Il passaggio al cessionario dell’azienda, che avvenga in forza dell’articolo 2112 del codice civile (norma applicata alle cessioni di rami aziendali), non dà luogo infatti a un nuovo rapporto di lavoro e il dipendente ceduto ha diritto di conservare lo statuto attuale e più produttivo (né il cessionario può avvalersi degli sgravi per i nuovi assunti). È evidente che in molti casi ciò costituirà un freno alle cessioni d’azienda: se teoricamente un simile effetto potrebbe considerarsi positivo, dato l’abuso che vi è stato in passato di tale istituto, si presenta certo il rischio che le attività vengano comunque esternalizzate con strumenti diversi, e scegliendo (o costituendo) nuove imprese che si avvalgano di nuovi assunti, aprendosi così un problema di eccedenza di personale nell’impresa cedente.
Questi e altri problemi inducono a chiedersi quale azione possano sviluppare le organizzazioni sindacali per contenere o controbilanciare i tanti effetti negativi delle nuove regole. A parte, ovviamente, le iniziative per ottenere dal legislatore aggiustamenti o ripensamenti, qualche spazio potrà essere recuperato, certo non facilmente, sul piano contrattuale. Qui la chiave potrà essere (a parte e ovviamente la condizione dei rapporti di forza) indurre la parte migliore delle imprese a contrastare effetti di ulteriore balcanizzazione dei mercati e delle relazioni sindacali, suscettibili di alzare i livelli di conflitto sociale e di determinare, comunque, effetti di impoverimento della qualità complessiva della produzione.
Se ciò viene compreso, potrebbero per esempio stipularsi accordi che incrementino il livello di indennizzo da licenziamento ingiustificato per i nuovi assunti, al fine di ridurre l’eccessiva differenza tra vecchi e nuovi dipendenti; oppure che creino percorsi di sostegno alla ricollocazione sul mercato del lavoro unitari, per entrambe le tipologie di lavoratori. Nulla impedisce, ovviamente, di stipulare accordi in base ai quali un’impresa o una pluralità di imprese riconoscano ai nuovi assunti lo stesso regime di tutela dei dipendenti già in servizio, ovvero attribuiscano loro in via negoziale la tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (conservando nel contempo i benefici contributivi, che derivano dalla disciplina di legge).
Per quanto difficile da ottenere, un simile impegno darebbe il senso di un forte investimento dell’impresasulla qualità e produttività del lavoro, connesse alla stabilità del rapporto, compensabili ovviamente con la disponibilità su altre forme di flessibilità della prestazione o dell’organizzazione del lavoro (magari con una maggiore disponibilità sui temi delle mansioni e del controllo della prestazione di lavoro, oggetto di prossime novità normative in attuazione della legge delega). Un tema sul quale la contrattazione dovrebbe intervenire con urgenza (qui sperando anche in aggiustamenti da parte del legislatore) è quello dell’apprendistato, al fine di contrastare la deriva negativa indotta oggi dal modifica gioco di convenienze (e avvalendosi della delega alla contrattazione prevista dall’articolo 2, comma 3 bis del dlgs 167/2011).
Una particolare attenzione deve essere dedicata agli accordi sui licenziamenti collettivi, dove la materia dei criteri di scelta deve essere governata con ancora più attenzione che in passato, in considerazione delle spinte che la differenza di convenienze tra mantenere in servizio dipendenti con statuto protettivo vecchio o nuovo può scaricare di fatto sulla selezione dei lavoratori interessati all’uscita. Ancora più complesso, certamente, è intervenire sui segnalati effetti distorsivi della concorrenza, ciò che rende non rinviabile una riflessione sul governo delle condizioni di lavoro nelle filiere produttive complesse, superando le barriere (anche in termini di rappresentanza) tra lavoratori rappresentati da diversi contratti collettivi. La battaglia sulla qualità del lavoro (e sulla qualità delle imprese coinvolte nella filiera produttiva) si fa ovviamente nell’interlocuzione con le imprese situate negli snodi di governo della filiera medesima, se e in quanto si riesca a rappresentare tutti o gran parte dei lavoratori collocati nei vari pezzi del processo produttivo.
La condizione di minor tutela del “nuovo assunto” può essere ridotta ove si riesca a creare e disciplinare, in modo virtuoso, mercati del lavoro “interni” a un settore produttivo, a un distretto, a una filiera, nei quali per esempio tutte le imprese si impegnino a riconoscere l’anzianità di servizio progressivamente maturata in quello specifico mercato (magari caratterizzato anche per l’adozione di specifiche politiche di formazione dei lavoratori). In questo senso, potrebbero ipotizzarsi meccanismi di mutualizzazione tra le imprese dei costi di licenziamento e di ricollocazione dei lavoratori.
Infine, si pone il difficile tema del governo dei settori economici caratterizzati dalla continua successione di appalti: qui la chiave sta ovviamente nel rapporto con le imprese committenti, anche avvalendosi degli spazi aperti dalla normativa legale (articolo 29 dlgs 276/2003), favorendo condizioni di maggiore competitività in cambio di garanzie per i lavoratori. Una prospettiva certo più facilmente percorribile ove avesse successo la proposta di legge di iniziativa popolare di recente presentata dalla Cgil (la quale mira tra l’altro a un forte sostegno delle clausole sociali, negli appalti sia privati sia pubblici).